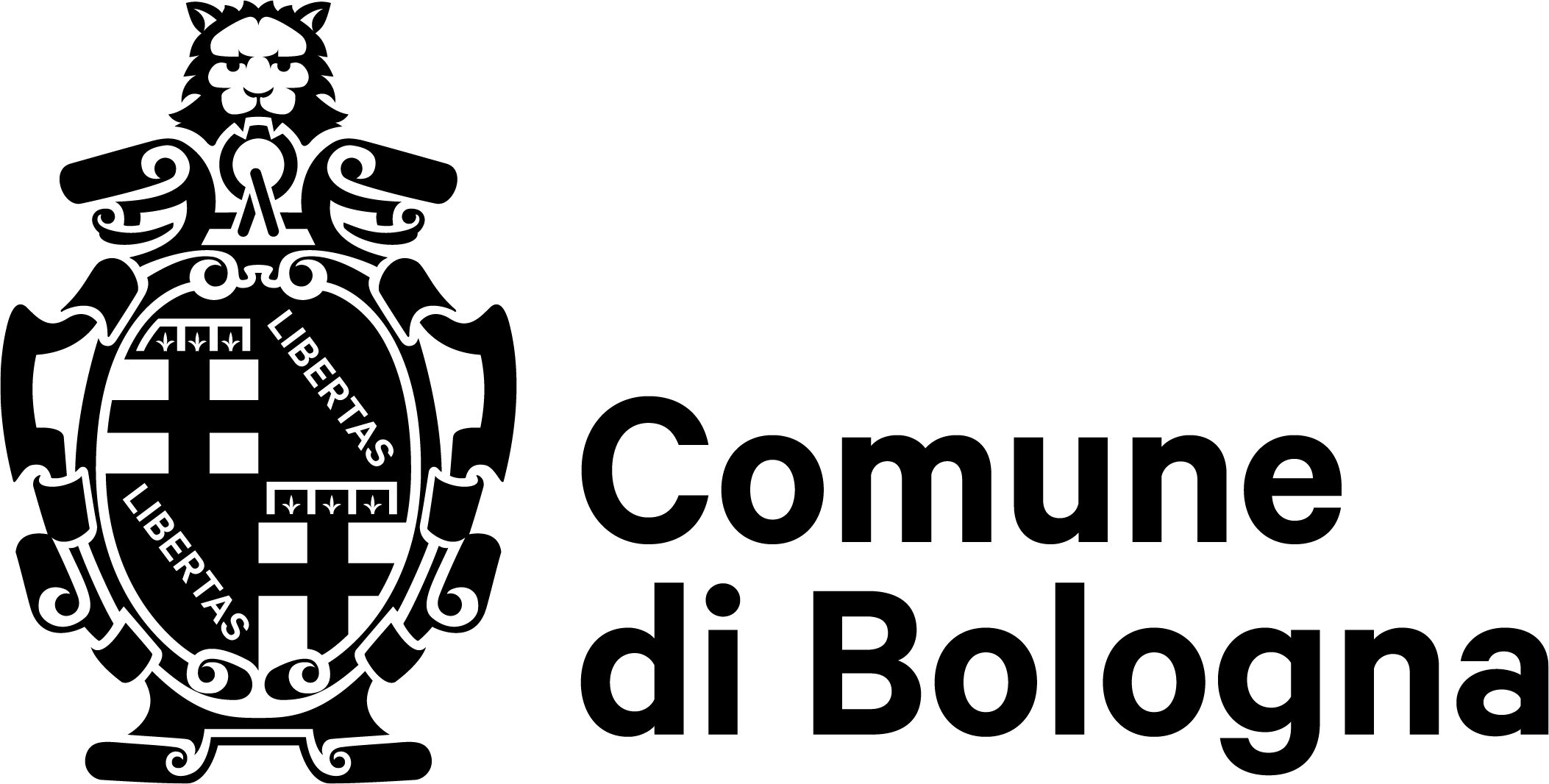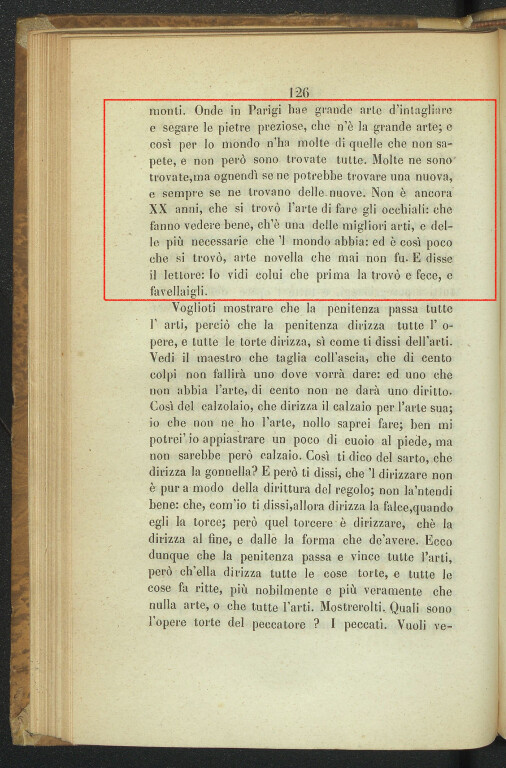
Album "Il nome della rosa"
In questa gallery raccogliamo documenti di varia natura che illustrano la genesi e la successiva vita editoriale del romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco, che fanno riferimento agli eventi e ai temi trattati nell’opera o che possono avere fornito una base informativa per l’autore. Riguardo a questo punto dobbiamo mettere le mani avanti (come non abbiamo mai fatto per gli altri libri letti dal Gruppo di lettura) per denunciare fin da ora che in alcune occasioni - sempre dichiarate - ci siamo divertiti ad azzardare e a proporre ipotesi che non hanno nessuna pretesa di essere dimostrate o dimostrabili. Ma se si fa una rassegna anche minima dei numerosi saggi o articoli dedicati al romanzo ci si accorge che gli stessi critici di professione hanno spesso azzardato e suggerito ipotesi poco fondate sulle fonti di Eco, tanto che lui stesso - lo vedremo - ha in alcuni casi dovuto stupirsi di quanto leggeva e, se lo riteneva necessario, rettificare. Dunque questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione del testo letterario (quando abbiamo presentato un’interpretazione critica è perché altri l’avevano già proposta e ci sembrava utile discuterne). Questo è il resoconto di un’esperienza di lettura, che si prende la libertà di azzardare un gioco - quello della ricerca di fonti, citazioni, allusioni - che è d’altra parte ben giustificato e anzi incoraggiato sia dall’Eco Autore Empirico che dall’Eco Autore Modello (riprendiamo una terminologia ben diffusa e presente in un saggio che incontreremo spesso, Interpretazione e sovrainterpretazione). Per noi bibliotecari-lettori un invito a nozze che non potevamo rifiutare.
Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1980. La paginazione è rimasta inalterata nelle numerose ristampe Bompiani che non facciano parte di una specifica collana, comprese quelle a cui sono state aggiunte le Postille a Il nome della rosa (nella gallery forniremo maggiori informazioni sulla vita editoriale del testo).
I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.
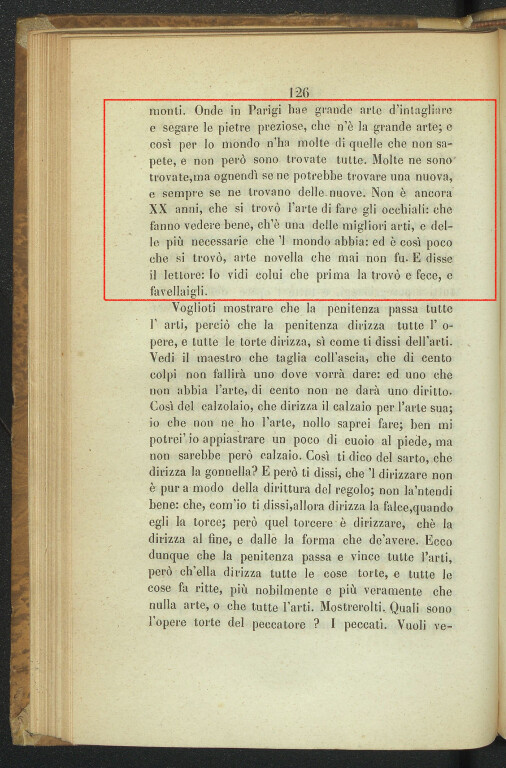
Gli occhiali di Guglielmo
Guglielmo si interessa anche delle applicazioni pratiche dello studio scientifico. Per rimanere nell’ambito dell’ottica non possiamo infatti trascurare l’importanza che hanno per lui - e per la trama del romanzo - gli occhiali. Quando gli vengono rubati i suoi «vitrei ab oculis ad legendum» (p. 94) si dispera perché non può leggere e quindi interpretare i segni e gli indizi - a partire dal messaggio cifrato lasciato da Adelmo - che possono portare alla verità. Anche in questo caso Eco ci fornisce una fonte documentaria:
«Nicola prese la forcella che Guglielmo gli porgeva con grande interesse: “Oculi de vitro cum capsula!” esclamò. “Ne avevo udito parlare da un certo fra Giordano che conobbi a Pisa! Diceva che non erano passati vent’anni da che erano stati inventati. Ma parlai con lui più di venti anni fa”.
“Credo che siano stati inventati molto prima”, disse Guglielmo» (ibidem).
Nicola il vetraio sta citando una famosa predica tenuta da fra Giordano da Pisa il 23 febbraio 1306 (1305 secondo il calendario fiorentino) in Santa Maria Novella a Firenze. Nel Quaresimale fiorentino 1305-1306 curato da Carlo Delcorno è la predica XV, p. 71-81 (il passo sugli occhiali è a p. 75). La vediamo qui in una edizione ottocentesca che la pubblica per la prima volta in una nuova lezione, curata da Enrico Narducci, insieme a tre prediche inedite dello stesso Giordano (conosciuto anche come Giordano da Rivalta o Rivalto).
Un dettaglio ha un significato importante per definire la differenza fra Guglielmo e gli altri monaci, anche quelli che coltivano interessi simili ai suoi. La cultura del vetraio Nicola è limitata alla sua esperienza diretta - ha presumibilmente ascoltato la predica di fra Giordano, le date coincidono - e al mondo cristiano in cui è stato allevato. Alla fine del romanzo, quando il cellario Remigio viene imprigionato, Nicola prende il suo posto. Possiamo supporre che svolga il mestiere di vetraio senza una reale preparazione teorica - le difficoltà che incontra nel fabbricare un nuovo paio di occhiali sembrano corroborare l’ipotesi - e che non sia così specializzato da non potere essere spostato dalle fucine alla cucina. Guglielmo invece sa qualcosa di più. Sa, anche se lo espone in forma falsamente dubbiosa, che gli occhiali sono stati inventati ben prima di quanto creda Nicola - probabilmente anche di quanto credesse Giordano - e sa che non è il mondo cristiano ma quello arabo ad avere realizzato i migliori studi di ottica, come abbiamo visto in precedenza parlando di specchi.
B. Giordano da Rivalto, Tre prediche inedite del B. Giordano da Rivalto, con la nuova lezione di una quarta, corredate di opportune notizie, e pubblicate per cura di Enrico Narducci, «Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti», n.s., CXLVI, gennaio-febbraio 1857, p. 71-133.