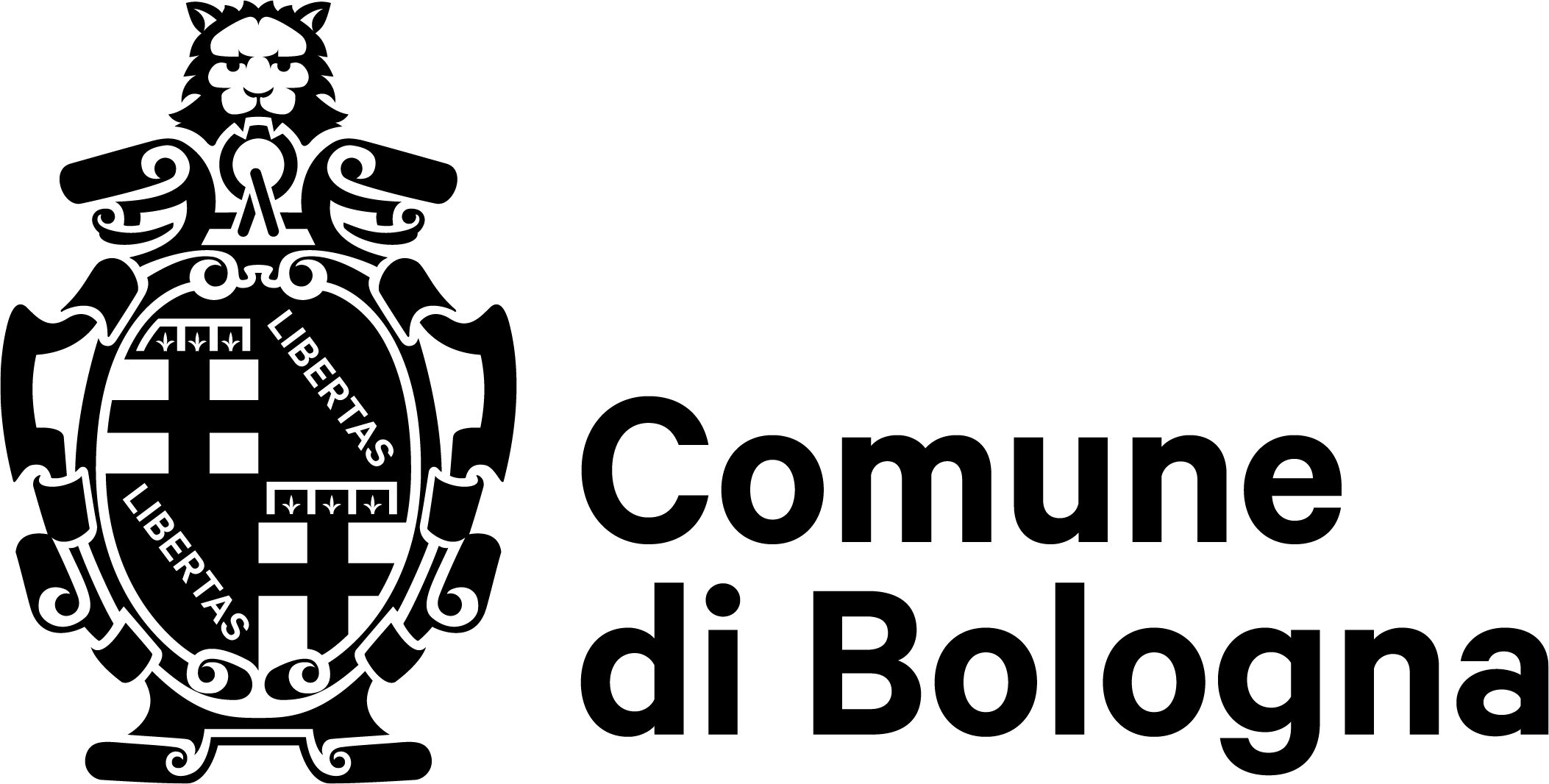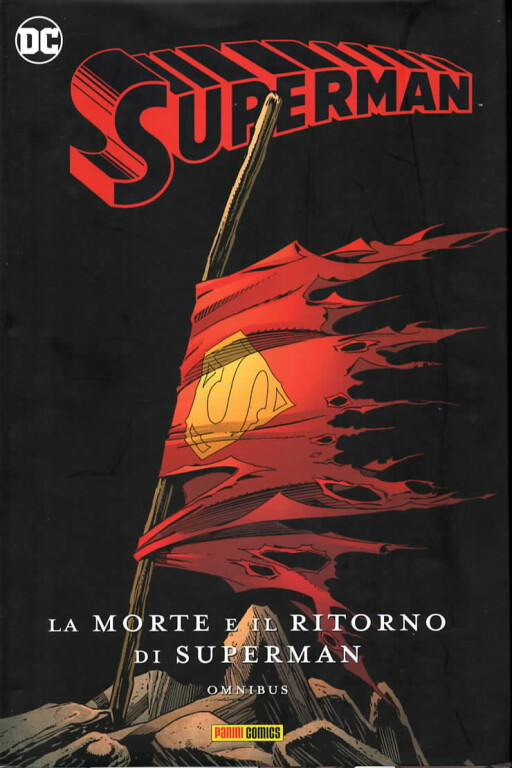
Album "Apocalittici e integrati"
In questa gallery raccogliamo documenti che illustrano la genesi e la vita editoriale del saggio Apocalittici e integrati di Umberto Eco (1964), che fanno riferimento ai temi trattati nell’opera o hanno fornito una base informativa per l’autore. Questa non vuole essere un’analisi scientifica ed esaustiva di fonti e documenti utilizzati dall’autore né tantomeno un’interpretazione critica del lavoro di Eco.
Quello che qui proponiamo è il resoconto di un’esperienza di lettura e di ricerca nel patrimonio della nostra biblioteca (con alcune escursioni su altre raccolte documentarie). Non solo non c’è pretesa di esaustività, poniamo anzi una dichiarazione preventiva del fatto che maggiore attenzione si è data alla parte relativa ai fumetti, considerata più interessante e adatta al percorso di lettura del nostro gruppo, mentre canzone e TV sono trattate qui in maniera episodica. Non si fanno inoltre quasi riferimenti ai capitoli Cultura di massa e “livelli” di cultura e La struttura del cattivo gusto, che naturalmente sono però la base teorica implicata nella presentazione dei documenti da noi preparata come del lavoro di analisi dei testi - grafici, testuali e sonori - fatta dall’autore.
Dove non diversamente specificato, l’indicazione delle pagine del romanzo citate si riferisce alla prima edizione, pubblicata nel 1964.
I documenti utilizzati sono quasi totalmente conservati e consultabili presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Salvo dove diversamente specificato la collocazione indicata è quindi relativa a questa biblioteca.
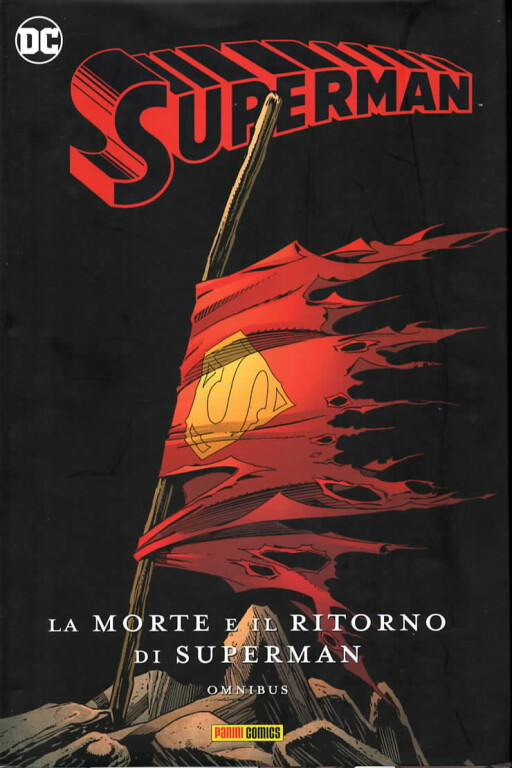
La morte e il ritorno di Superman (2020)
Eco intitola uno dei paragrafi dedicati a Superman Intreccio senza consumo (p. 239-244). Le storie vivono «nell’illusione di un continuo presente» (p. 244) e il personaggio - come i personaggi del mito - non si consuma mai, ma a ogni episodio riparte dallo stesso punto in cui lui e il suo mondo si trovavano all’inizio dell’episodio precedente. Questo, più che la sua invulnerabilità, presuppone il fatto che Superman non possa morire.
Invece nel 1992 Superman muore, ucciso dal supernemico Doomsday. La quarta di copertina del volume che nel 2020 ripropone quegli episodi esalta «L’epico evento che ha sconvolto il mondo e cambiato Superman per sempre» e lo celebra come una delle storie fondamentali per il fumetto moderno. Ma ha senso dire che la morte di Superman lo ha cambiato per sempre? Come può cambiare se è morto? La risposta sta nel titolo di questo volume di 1370 pagine che raccoglie un anno e mezzo di episodi usciti su diverse testate: dopo la morte c’è stato il ritorno. Per quasi un anno e mezzo il mondo DC Comics è andato avanti senza Superman: uno sforzo creativo e logistico incredibile e stupefacente, che ha comportato la “sincronizzazione” delle storie raccontate in tutte le diverse testate pubblicate. Ma alla fine il supereroe per antonomasia deve tornare, altrimenti quel mondo crollerebbe. Perché aveva ragione Eco: Superman non può consumarsi e morire.
Anche nella morte Superman in realtà non si è consumato. Muore infatti “giovane”, per quanto abbia senso parlare con i nostri criteri temporali di un alieno. Non è invecchiato. Muore in battaglia in maniera improvvisa. Si veda la differenza con un’altra storia DC, Il ritorno del Cavaliere oscuro di Frank Miller, in cui un Bruce Wayne non anziano ma invecchiato e “pensionato” decide di tornare a vestire i panni di Batman. Quella storia cambia veramente il mondo del fumetto. La morte di Superman è un evento indelebile che non modifica niente di sostanziale.
Quando Superman torna non è «cambiato per sempre» come strilla la quarta di copertina. È sempre lui, il solito salvatore del mondo che però, come dice Eco, non decide mai di fare quello che potrebbe realizzare senza alcuno sforzo: prendere veramente il potere e imporre i suoi superiori valori morali. Non lo fa perché la sua storia così finirebbe, pur senza essere morto.
Superman. La morte e il ritorno di Superman, Modena, Panini Comics, 2020.